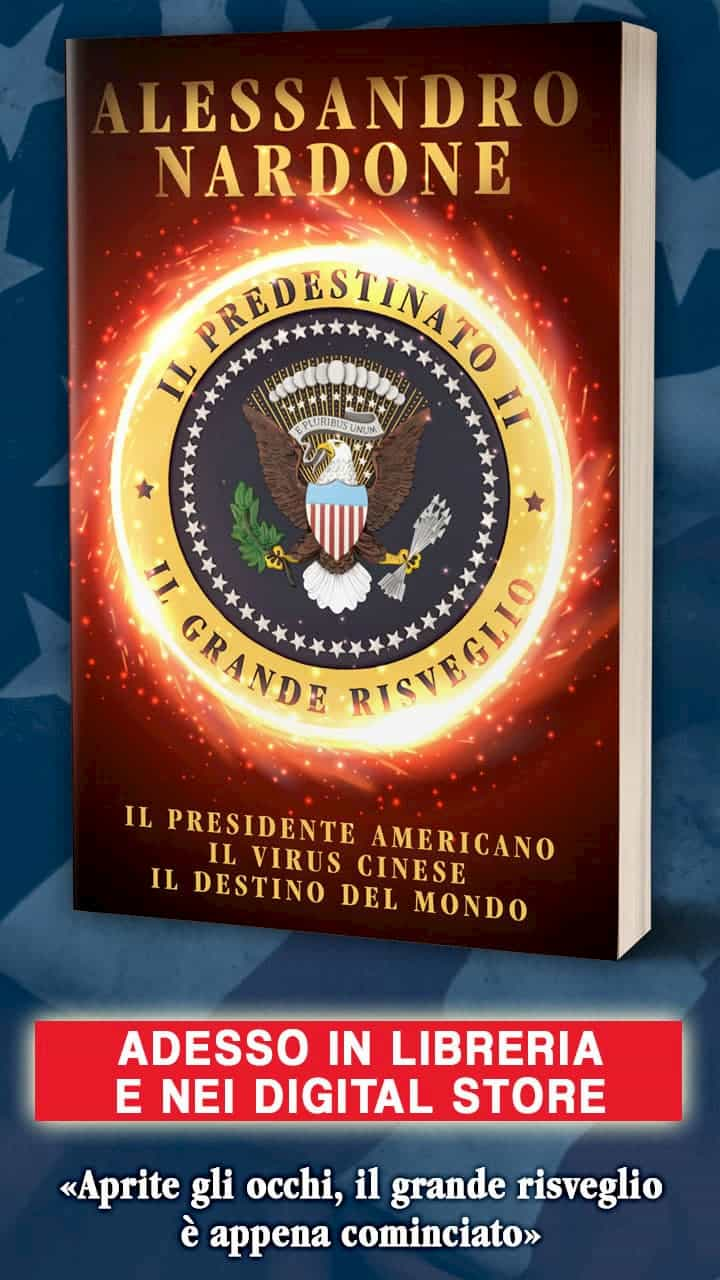La carriera giornalistica di Luca Rigoni inizia nel 1988, dopo la laurea con lode in Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo, presso la facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna, con una tesi in Storia del cinema. Ha lavorato alla Rai corporation di New York dal 1989 alla fine del 1991. Per il TG5 di Mediaset, dove lavora dalla fondazione assunto da Enrico Mentana, ha seguito come inviato i principali avvenimenti internazionali: sei elezioni presidenziali americane (nel 2004 era a Washington nel quartier generale di George W. Bush, nel 2008 e 2012 a Chicago in quello di Barack Obama), due Midterm (2006 e 2010), numerosi vertici internazionali, incluso il G8 di Genova nel 2001 e quello dell’Aquila nel 2009, il dopo 11 settembre 2001 da Washington, l’uragano Katrina da New Orleans.
È stato in Somalia e in Afghanistan, a Londra nel 2005 e nel 2006 per gli attentati e l’allarme terrorismo, e molte volte in Medio Oriente. Ha intervistato, fra gli altri, gli ex segretari di Stato americani Henry Kissinger, Colin Powell e Condoleezza Rice, l’ex premier israeliano Ehud Olmert, il premier turco Erdogan. Il 2 aprile 2005, in uno speciale del TG5, ha dovuto annunciare in diretta la morte di Giovanni Paolo II. Ha condotto il TG5 della notte e l’edizione del pomeriggio. In seguito, con l’approdo alla direzione del TG5 di Clemente J. Mimun, ha condotto l’edizione delle 13 in coppia con Elena Guarnieri o Monica Gasparini, fino al 1º ottobre 2009. Dopo essere stato caporedattore della redazione Esteri del TG5, nel novembre 2011 passa a TGcom24.
Questa è la biografia di Luca Rigoni che trovate sulla sua pagina di Wikipedia, da cui mi risulta oggettivamente impossibile tagliare qualcosa. Luca è un professionista straordinario oltre che un galantuomo, e non esagero – chi mi conosce sa che non non sono assolutamente un tipo dal complimento facile – affermando che vivo la nostra amicizia come un autentico privilegio, poiché ogni confronto è un vero e proprio momento di crescita. Ricordo quando lessi per la prima volta la prefazione che scrisse a Yes Web Can, libro in cui insieme a Carlo Cattaneo e Antonino Caffo raccontammo con dovizia di particolari la mia candidatura fake alle presidenziali americane del 2016, soffermandomi in particolare su un passaggio che oggi trovo di grandissima attualità: «e se Alex Anderson fosse davvero nato e cresciuto negli Stati Uniti? E se Alex fosse davvero salito sulla pedana del circo, con Snowden come spalla, come suo vice-clown? Se davvero avesse affrontato le platee e i dibattiti tv? Dove sarebbe arrivato? O meglio: a che punto si sarebbe – o sarebbe stato – fermato?»
Ormai, scrivere un articolo giornalistico significa, spesso, dover trovare qualcosa che non solo possa essere interessante per il lettore, ma che abbia anche gli elementi giusti a livello di immagine (foto, video e audio) per poter diventare virale sui social: questo, a suo avviso, limita o esalta la capacità di scelta del giornalista?
Appartengo a una generazione professionale che guardava alla carta stampata come al raggiungimento delle proprie aspirazioni. La firma in prima pagina, allora, credevamo valesse molto più della conduzione di un tg o di una trasmissione o di una ospitata televisiva. Meglio al Corriere della Sera che al Tg1, per dirla in modo secco. Una questione di stile, di possibilità di approfondimento, di visibilità presso certi ambienti, anche. Il grande inviato. Il corrispondente. L’editorialista. Il corsivista. Capite quanto tempo è passato. C’era solo la Rai, quando ci affacciavamo al lavoro giornalistico. E c’erano le grandi corazzate della carta stampata, apparentemente inaffondabili. Sembravano, come dire, “il giro giusto”. Per molti di noi la televisione – c’erano posti, assumeva – fu un ripiego. Che sonora fesseria!
Ora che tutto è cambiato, oltre un quarto di secolo dopo, ci è però difficile – o mi è difficile – non vedere il disastro informativo che ci circonda. E’vero che il web garantisce immediatezza, bassi o nulli costi, larghissima e capillare diffusione. Velocità e impatto. Ma non si può non osservare che l’orizzontalità dell’informazione su internet, l’assenza di gerarchie, l’uno vale uno, l’opinionismo senza limitismo, come direbbe Dagospia, la percezione che tutto possa essere gratuito, che ognuno possa dire la sua su tutto, una distorta visione di democrazia nell’informazione e nella comunicazione, abbiano scalfito profondamente il lavoro giornalistico. Il giornalista può scegliere solo SE può scegliere. Se la capacità di scelta ce l’ha, senza dimenticare, ovvio, che altri limiti e altre censure gravavano e gravano su questo lavoro. Se ha un posto fisso o un buon contratto di collaborazione, se può dire dei no (anche morbidi, per carità) perché sa che non lo licenzieranno o che ci sarà qualcun altro ad assumerlo. Se è periclitante, a tempo determinato, che scelte potrà fare?
Non voglio che questa sembri una difesa sindacale della categoria, né mitizzare una professione: ci sono anche troppi “cani da guardia” nei film americani. Piuttosto, far capire che non si lavora più bene in tante, troppe redazioni. E quindi le immense opportunità della rete, se non sono sempre a vantaggio dei giornalisti, non lo sono nemmeno dei lettori.
Spesso si sente dire che Internet è il posto delle “fast-food news”, perché ormai gli utenti hanno poco tempo e leggono solo notizie brevi. Tuttavia, di recente, c’è chi si è inventato le “slow news” come alternativa a questo approccio. Lei da che parte sta?
Il mondo del web, paradossalmente, o forse no, è solo ai primi passi. Ma già si stanno creando fasce e tipologie di lettori diverse. Chi morde e fugge, chi va su altri siti e vuole approfondire. E’ un’editoria alle prime armi, che infatti si deve spesso appoggiare alla vecchia editoria per i contenuti. Pensiamo alla carta stampata, da Gutenberg a oggi. Siamo solo agli albori, in realtà, di quello che verrà. L’importante – e torno al discorso di prima – è che la rete non cannibalizzi soltanto. Ma crei, oltre al capitale, anche la forza lavoro. In parte è già così. Ma siamo all’inizio. E in ogni caso, tutto, nell’organizzazione del lavoro giornalistico è destinato a cambiare. Sta già cambiando.
Come scriveva Walter Lippmann, le notizie formano una sorta di pseudo-ambiente, ma le nostre reazioni a tale ambiente non sono affatto pseudo-azioni, bensì azioni reali. È evidente che il fenomeno fake news vada ben oltre le classiche “bufale” e che prolifichi a seguito della ricerca spasmodica di “like” e di visualizzazioni. Secondo lei cosa manca ai media, e ai giornalisti più in generale, per riconquistare la credibilità perduta?
Ci sono i fatti, e c’è poi un punto di vista – o molti – per guardarli. Poi ci sono i non-fatti e un punto di vista – o molti – per guardarli. Se media e giornalisti in crisi di copie e di lavoro preferiscono guardare ai non-fatti – o inventarli – per stare al passo con lettori o telespettatori già indottrinati o convinti di qualcosa, be’, si facciano una ragione del declino della loro professione. Se la politica, non solo italiana, è in campagna elettorale permanente e deve attizzare le rabbie e gli orgogli nelle proprie tifoserie, si faccia una ragione del declino della politica. Insomma, ognuno è responsabile delle proprie azioni. E solo un ritorno alla responsabilità (anche se le fake news sono sempre state il sale di ogni campagna elettorale e di ogni conflitto: oggi il web le fa penetrare di più) può cambiare le cose. Sono pessimista: perché questo – un giornalismo e una politica di contenuti se non alti perlomeno adeguati – è un discorso, si direbbe adesso, elitario, in fondo. E anche un po’ chic. Ma i tempi cambieranno.
Come detto, in Italia così come altrove, la popolarità professionale dei giornalisti (e della professione giornalistica) è ai minimi storici. Qual è, secondo lei, l’errore più grave che commettono gli operatori del settore?
Nessuno può dare lezioni. Però non si può rincorrere sempre la pubblica opinione. L’uno non vale uno: piaccia o meno. Bisogna ritornare a una verticalità dell’informazione… e sì, a un principio di auctoritas. E bisogna anche accettare, quando capita, l’impopolarità o le posizioni minoritarie. Tanto poi le cose cambiano. Il New York Times – lasciamo perdere gli attacchi di Trump – è più o meno credibile da quando, in agosto, ha cambiato il titolo di prima pagina sul presidente per rispondere all’onda delle proteste via web?
Al di là di quello che ritiene qualche politico ci pare evidente ormai, a livello globale, che il bipolarismo non sia più tra destra e sinistra, bensì tra élite di garantiti e popolo dei non rappresentati. A questo si aggiunge il paradosso tutto italiano di una democrazia orfana degli spazi in cui una classe dirigente possa nascere e crescere per formazione e non per cooptazione. Su quali basi e con quali strumenti (anche informativi) sarà possibile – secondo lei – costruire una nuova e autentica connessione tra popolo e classi dirigenti?
In Italia non ci sono mai state classi dirigenti così “popolari”, mi permetto di dire. Si è trattato di una discesa delle classi dirigenti, beninteso, non di una salita del popolo. Anzi: c’è stata anche una salita del popolo, che per salire però ha preso le scorciatoie della politica. C’è una sola parola d’ordine, io credo: educazione. Educazione. Educazione. Migliori scuole e università, migliore integrazione fra studio e lavoro. Vale anche per il giornalismo: migliore informazione, più attenta, più preparata, più – posso dirlo? – colta. Mi pare che da noi si vada in senso ostinatamente contrario.
Come accadde in passato con la televisione, oggi sono le esigenze del Web a controllare la nostra cultura e, in Internet, si vive o si muore di click, perché garantiscono potere e profitti della pubblicità. Esiste, secondo lei, un modo per superare il dualismo Google-Facebook?
Ripeto: siamo ancora ai primissimi passi di Internet. Facebook e Google la fanno ora da padroni, così come Amazon, ma inevitabilmente nuovi sfidanti si stanno preparando. Basta solo pensare alla sfida per il predominio nella telefonia fra Usa e Cina. E’ in atto un conflitto mondiale che riguarda – appunto – la comunicazione globale. Spiace che l’Europa sia di fatto una spettatrice.
Grazie a Snowden sappiamo che Orwell aveva ragione e che ogni singola azione che compiamo online viene intercettata, monitorata e catalogata. Questo significa controllo, che a sua volta è un sensazionale strumento di potere aumentato dalle “censure” imposte grazie ai luoghi comuni politicamente corretti. Quanto di questo “totalitarismo tecnologico”, ritiene che sia oggettivamente colpa di chi dovrebbe informare correttamente, ovvero dei giornalisti?
Perché, in passato non è stato così? Certo, ora il controllo è su scala globale, e usa altri mezzi, ma sotto i regimi dittatoriali, totalitari appunto, non vi era e non vi è un controllo altrettanto capillare? Con le democrazie si pone una questione diversa. Però non credo che la Casa del Potere, che è anche una House of Cards, possa essere trasparente. E’ un’utopia. Se il “lasciateci lavorare” non è accettabile, non è nemmeno accettabile l’interferenza continua, gli spifferi informativi permanenti. Ve li immaginate con Churchill durante il secondo conflitto mondiale? I giornalisti ci guardino pur dentro, questa casa, con gli strumenti che posseggono, con cura e attenzione, ma anche con responsabilità.
Quanto a Snowden ha dei meriti, ma ha fatto parecchi danni, no? E per conto o a favore di chi?
Una delle suggestioni più frequenti tra gli addetti alla informazione è quella “robot journalism”, una definizione che viene associata all’uso di software in grado di realizzare testi di senso compiuto senza l’intervento dell’uomo. In prospettiva, lo vede più come un’opportunità o una minaccia?
Che meraviglia! Non vedo l’ora. Purché gli editori ci mandino il salario a casa a fine mese. In cambio, beninteso, delle nostre acutissime analisi e più o meno inutili opinioni. Il lavoro di cucina se lo smazzino finalmente i robot! Certo, dal New Journalism col quale siamo cresciuti al Robot Journalism il passo è stato enorme, mi auguro non fatale.
Secondo lei esiste una anche remota possibilità che il giornalismo – inteso come istituzione – possa scomparire per essere sostituito da un nuovo modo di trasmettere la conoscenza alle persone magari in maniera “meccanica”, o comunque con la definitiva affermazione del principio di induzione che attualmente gli algoritmi utilizzano per “selezionare” le notizie al posto nostro?
Come sopra. Un sacco di validi colleghi già sono costretti a fare il copia-incolla delle agenzie. E molti ci appiccicano sopra delle immagini, anch’esse di agenzia. Gli algoritmi forse lo faranno con meno fatica. E gratuitamente, per gli editori, una volta ammortizzati i costi.
Forse il grosso dei lettori-spettatori in effetti ritiene di non aver bisogno di molto di più, ma da sempre è così. Il già ricordato New York Times non è mai stato per tutti gli americani, ma per le élites newyorkesi (erano pur sempre tantissime copie, una vasta, grande élite: più vicina a Saul Bellow che a Johnny Carson, e in ogni caso finivano in sezioni diverse del giornale). Basta pensare all’edizione faraonica della domenica. Solo chi ha una valanga di tempo libero ed è senza figli piccoli poteva o può leggerla, a partire dalla notte del sabato. Ma pure sfogliarla aiuta.
Che cosa ha schiantato il ruolo e il lavoro del corrispondente? Il web. Il tuo direttore, spesso, a causa dei fusi orari, ha già letto quanto ti appresterai a leggere tu al risveglio. E – aggiungo senza reticenze – a utilizzare come fonte di ispirazione per i tuoi pezzi. Sto usando un’espressione soft. Ma resta molto spazio nel settore delle inchieste e dei reportages: anche dall’estero. Chi è sul campo deve andare “oltre”: lo si è sempre detto, molti lo hanno fatto, ora devono farlo tutti.
Poi, anche il web diventerà per spicchi elitario, già qui e lì lo è. Sta diventando grande.
Come leggeremo le notizie tra 5 anni?
Come adesso, ma più in fretta e molto meglio. Sul telefonino.